Sono parecchi i racconti aventi per protagonisti cani feroci o mansueti, a seconda dei casi, che a un certo punto della storia si mettono a parlare lasciando di stucco i loro interlocutori. Quelli che seguono sono solo alcuni esempi di tale razza canina. Un boscaiolo di Alzano stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di duro lavoro nei boschi di Gavarno. Camminava lentamente lungo la mulattiera rischiarata un poco dalla fievole luce della luna. Ad un tratto notò davanti a sè un cane bianco che scodinzolava e sembrava desideroso della sua compagnia. Alquanto sorpreso per quella inattesa apparizione, ma abbastanza tranquillo per l’atteggiamento tutt’altro che minaccioso dell’animale, il boscaiolo proseguì il cammino, mentre il nuovo venuto scorrazzava un po’ davanti e un po’ dietro a lui. Arrivato vicino a casa e visto che il cane non accennava ad andarsene, anzi sembrava averlo eletto a suo padrone, il viandante gli si avvicinò e allungò la mano con l’intenzione di accarezzarlo. Ma la sua sorpresa fu grande quando l’animale, arrestatosi di colpo e aperta la bocca, gli chiese: “Che cosa vuoi da me?”. Ciò detto, se ne sparì nel folto del bosco, lasciando il boscaiolo con il braccio ancora proteso in avanti, in preda a un comprensibile terrore. Riavutosi un poco, si precipitò verso casa, ma non ebbe la forza di raggiungerla e cadde svenuto in mezzo alla strada. Qui fu trovato qualche ora più tardi dai parenti, allarmati per il suo insolito ritardo.
Gli ci vollero un paio di mesi per ristabilirsi e dopo di allora il boscaiolo di Alzano non ebbe più il coraggio di passare da solo per quella strada. Anche la storia che segue, intitolata ol cagnì, e raccontata da un’anziana donna della media Valle Brembana, ha per protagonista un cane parlante il quale, a differenza degli altri, si rivela buono e incaricato di una missione di salvezza. La riportiamo nel dialetto dell’informatrice.
Öna ölta gh’era öna tusa che la gh’era öna madrégna catìa, che la ga ülìa miga be. Ü dé la madrégna la ga dis a sta tusa: “‘Ndèm che ‘n va ‘n dèl bosc a per ciclamini!”. Quande chi è stade ‘n dèl bosc, cola scüsa dè ‘nda a èt ü laùr, la madrégna l’a lagà la tusa dè per le e l’è scapàda a ca. La tusa, piena dè pura, l’a cimà töta la sìra e l’a sircà la strada per turnà a ca, ma sensa truàla. Quande l’è sta nòcc, l’a truà öna baita e la gh’è riàda a ‘nda dè dét e l’a cumincià a dormé. La matina la sét chi pica àla porta e töta spaentàda, la ‘a a èrs. ‘L gh’è dè fò ü cagnì, con d’ü fagutì ligà sö al còl, che ‘l ga dis: ” ‘L ma manda ol tò angel cüstòde dèl Paradìs, ta gh’é dè dé sö tre ave Marie che domà ‘l vé la Madona a töt, ‘n chesto fagutì gh’è ét öna fèta dè polénta, ü michét dè pà e ‘n po’ dè formài”. La matina dopo la sét chi ciàma fò dela baita, la ‘a a èt e la èt la Madona che la l’a istìda dè bianc, con d’ü nastro blö e la l’a portàda ‘n ciél.
Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001
Sono parecchi i racconti aventi per protagonisti cani feroci o mansueti, a seconda dei casi, che a un certo punto della storia si mettono a parlare lasciando di stucco i loro interlocutori. Quelli che seguono sono solo alcuni esempi di tale razza canina. Un boscaiolo di Alzano stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di duro lavoro nei boschi di Gavarno. Camminava lentamente lungo la mulattiera rischiarata un poco dalla fievole luce della luna. Ad un tratto notò davanti a sè un cane bianco che scodinzolava e sembrava desideroso della sua compagnia. Alquanto sorpreso per quella inattesa apparizione, ma abbastanza tranquillo per l’atteggiamento tutt’altro che minaccioso dell’animale, il boscaiolo proseguì il cammino, mentre il nuovo venuto scorrazzava un po’ davanti e un po’ dietro a lui. Arrivato vicino a casa e visto che il cane non accennava ad andarsene, anzi sembrava averlo eletto a suo padrone, il viandante gli si avvicinò e allungò la mano con l’intenzione di accarezzarlo. Ma la sua sorpresa fu grande quando l’animale, arrestatosi di colpo e aperta la bocca, gli chiese: “Che cosa vuoi da me?”. Ciò detto, se ne sparì nel folto del bosco, lasciando il boscaiolo con il braccio ancora proteso in avanti, in preda a un comprensibile terrore. Riavutosi un poco, si precipitò verso casa, ma non ebbe la forza di raggiungerla e cadde svenuto in mezzo alla strada. Qui fu trovato qualche ora più tardi dai parenti, allarmati per il suo insolito ritardo.
Gli ci vollero un paio di mesi per ristabilirsi e dopo di allora il boscaiolo di Alzano non ebbe più il coraggio di passare da solo per quella strada. Anche la storia che segue, intitolata ol cagnì, e raccontata da un’anziana donna della media Valle Brembana, ha per protagonista un cane parlante il quale, a differenza degli altri, si rivela buono e incaricato di una missione di salvezza. La riportiamo nel dialetto dell’informatrice.
Öna ölta gh’era öna tusa che la gh’era öna madrégna catìa, che la ga ülìa miga be. Ü dé la madrégna la ga dis a sta tusa: “‘Ndèm che ‘n va ‘n dèl bosc a per ciclamini!”. Quande chi è stade ‘n dèl bosc, cola scüsa dè ‘nda a èt ü laùr, la madrégna l’a lagà la tusa dè per le e l’è scapàda a ca. La tusa, piena dè pura, l’a cimà töta la sìra e l’a sircà la strada per turnà a ca, ma sensa truàla. Quande l’è sta nòcc, l’a truà öna baita e la gh’è riàda a ‘nda dè dét e l’a cumincià a dormé. La matina la sét chi pica àla porta e töta spaentàda, la ‘a a èrs. ‘L gh’è dè fò ü cagnì, con d’ü fagutì ligà sö al còl, che ‘l ga dis: ” ‘L ma manda ol tò angel cüstòde dèl Paradìs, ta gh’é dè dé sö tre ave Marie che domà ‘l vé la Madona a töt, ‘n chesto fagutì gh’è ét öna fèta dè polénta, ü michét dè pà e ‘n po’ dè formài”. La matina dopo la sét chi ciàma fò dela baita, la ‘a a èt e la èt la Madona che la l’a istìda dè bianc, con d’ü nastro blö e la l’a portàda ‘n ciél.
Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001
In cima al monte c’era una casa che stava in mezzo ad un prato. Pur essendo una bella casa, nessuno la voleva abitare perché già abitata: era la casa degli spiriti. Un inverno, una squadra di uomini che raccoglieva tronchi d’albero in quel luogo, giunti a sera dopo una giornata di lavoro, decisero di andare a dormire proprio in quella casa. Quando hanno aperto la porta, videro sotto il portico topi scappare, rospi saltare da ogni parte, ragni sul muro grossi come il pugno di una mano. Lasciati a terra i loro ferri, corde, scuri, zappe, gli uomini che non avevano paura alcuna, salirono le scale e arrivati al piano superiore, videro nella stanza volare pipistrelli e civette e cornacchie che facevano versi.
Ma la stanchezza era tale, che presa una bracciata di fieno per ciascuno e una coperta, si buttarono a terra e cominciarono a dormire. Giunta la mezzanotte, avvertono che la porta si apre e sentono entrare un gruppo di gente che fa rumore; gridano, piangono ed emettono suoni che non sembrano neppur essere di cristiani; e per di più s’accorgono che questa gente adopera i loro ferri per tagliare la scala di legno; e dopo poco le finestre e le porte cadono a pezzi, e tutto crolla finche’ alla fine rimane soltanto il tetto. Dopo questi fatti la paura ha incominciato a prender l’animo degli uomini e quando il più coraggioso della squadra ha tentato di alzarsi, sé sentito in dosso due mani fredde che gli impedivano di muoversi. Ma lui non convinto, ha fatto per scagliare uno scarpone contro quello che non vedeva: ma in quel momento stesso un manrovescio lo colpiva sui denti. Allora sbalordito e pieno di paura, anche quello che era ritenuto il più coraggioso di tutti, si è stretto vicino ai suoi compagni spaventato. Fra baccano e rumori, la notte non passava più.
Quando è venuto il giorno, tutto s’è quietato e gli uomini più morti che vivi, si sono alzati: con grande meraviglia hanno constatato che le scale le porte e le finestre e i loro ferri, erano tutti al loro posto. Gli uomini ripresero i loro arnesi e, usciti dalla casa, si sono messi a correre giù per il prato, finche’ hanno avuto fiato. Quando furono ben lontani, si voltarono per dare ancora un’occhiata a quella casa, ma con grande stupore s’accorsero che era sparita: al suo posto era rimasto un gran mucchio di spini. Ancor oggi quelli che passano da queste parti, vedono in mezzo al prato il cespuglio di spini e con terrore pensano alla casa degli spiriti.

 La baita della capra (Carona)
La baita della capra (Carona) Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca
Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca La pitocca di Olda di Val Taleggio
La pitocca di Olda di Val Taleggio Cani parlanti
Cani parlanti La strega nel fenile della pastora di Poscante
La strega nel fenile della pastora di Poscante La caccia selvatica o cacciamorta
La caccia selvatica o cacciamorta Il castello della Regina
Il castello della Regina Il Drago volante di Santa Brigida
Il Drago volante di Santa Brigida Il lupo di Stabello
Il lupo di Stabello La cassa da morto del Diavolo
La cassa da morto del Diavolo La casa degli spiriti
La casa degli spiriti Il Folletto della Val Taleggio
Il Folletto della Val Taleggio La càvra del Zambèl
La càvra del Zambèl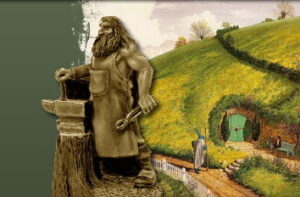
 La leggenda del Monte Avaro di Cusio
La leggenda del Monte Avaro di Cusio La Maga dei bambini
La Maga dei bambini La matrignia di Spino al Brembo
La matrignia di Spino al Brembo Il mandriano spergiuro
Il mandriano spergiuro Ifuochi di Sant’Antonio
Ifuochi di Sant’Antonio La leggenda della Val d’Inferno (Ornica)
La leggenda della Val d’Inferno (Ornica)
 Briganti e brigantesse
Briganti e brigantesse Gatti permalosi e gatte cornie
Gatti permalosi e gatte cornie Streghe bollite in pentola
Streghe bollite in pentola Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle
Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle Il prete della Valle di Poscante
Il prete della Valle di Poscante
 Il morto che tirava le gambe di notte
Il morto che tirava le gambe di notte


