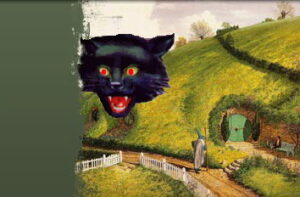Molti anni fa, a Poscante, c’era una famiglia i cui componenti si dilettavano a suonare gli strumenti musicali ed in particolare il baghèt, o piva delle Alpi, con il quale erano soliti allietare le feste popolari, recandosi nelle contrade dei dintorni per offrire ai paesani quelle rare occasioni di svago consentite dai rigidi costumi di allora. Andavano nei paesi senza altro scopo che di festeggiare e fare baldoria, portando al seguito un asinello carico di una botticella di vino da vendere alle allegre compagnie che li aspettavano per concludere in bellezza una giornata vissuta all’insegna del divertimento, prima di riprendere all’indomani le consuete fatiche quotidiane. Una sera questi suonatori erano partiti, come al solito, col loro carico di vino e strumenti musicali e si erano diretti al Monte di Nese per la festa di Sant’Antonio abate. Arrivati nei pressi della Forcella, dalla quale si scollina per scendere lungo il versante opposto, fecero una breve sosta e, volgendosi verso Poscante, notarono con spavento che una casa del paese era avvolta nelle fiamme. Guardarono meglio e si accorsero che la casa incendiata era proprio la loro. In preda ad una forte preoccupazione, tornarono di corsa verso Poscante, nel disperato tentativo di spegnere le fiamme e salvare almeno qualcosa delle loro masserizie; ma arrivati in prossimità del paese si avvidero, con grande stupore, che non c’era nessun incendio: tutto era tranquillo e le famiglie erano ormai andate a dormire. Ripresero allora la strada verso il Monte di Nese, ma ecco che, giunti alla Forcella, si ripeté lo stesso fenomeno di poco prima e la loro casa apparve nitidamente avvolta dalle fiamme.
Altra corsa precipitosa verso Poscante ed altro stupore nel notare che non era in corso nessun incendio. Però, per meglio sincerarsi, questa volta raggiunsero la loro casa dove trovarono i parenti tranquillamente addormentati. Di nuovo risalirono, pur con malavoglia, verso la Forcella dove per la terza volta si ripeté la visione della loro casa in preda ad un furioso incendio. Questa volta il ritorno verso Poscante fu meno precipitoso, ma accompagnato da un’attenta riflessione sul possibile significato di quel fenomeno, che la compagnia interpretò, alla fine, come un monito di Sant’Antonio a rimanersene a casa e smettere di portare nei paesi vicini occasioni di festa peccaminosa, perché basata sul ballo e sulle abbondanti bevute. Quella sera i suonatori fecero voto a Sant’Antonio di porre fine alla loro festosa attività e di dedicare l’intera giornata della festa del santo abate ad onorarne la memoria. La festa fu rispettata anche negli anni seguenti e da allora pare che i Cornolti, questo era il casato dei suonatori, abbiano sempre mantenuto la promessa.
Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001
Molti anni fa, a Poscante, c’era una famiglia i cui componenti si dilettavano a suonare gli strumenti musicali ed in particolare il baghèt, o piva delle Alpi, con il quale erano soliti allietare le feste popolari, recandosi nelle contrade dei dintorni per offrire ai paesani quelle rare occasioni di svago consentite dai rigidi costumi di allora. Andavano nei paesi senza altro scopo che di festeggiare e fare baldoria, portando al seguito un asinello carico di una botticella di vino da vendere alle allegre compagnie che li aspettavano per concludere in bellezza una giornata vissuta all’insegna del divertimento, prima di riprendere all’indomani le consuete fatiche quotidiane. Una sera questi suonatori erano partiti, come al solito, col loro carico di vino e strumenti musicali e si erano diretti al Monte di Nese per la festa di Sant’Antonio abate. Arrivati nei pressi della Forcella, dalla quale si scollina per scendere lungo il versante opposto, fecero una breve sosta e, volgendosi verso Poscante, notarono con spavento che una casa del paese era avvolta nelle fiamme. Guardarono meglio e si accorsero che la casa incendiata era proprio la loro. In preda ad una forte preoccupazione, tornarono di corsa verso Poscante, nel disperato tentativo di spegnere le fiamme e salvare almeno qualcosa delle loro masserizie; ma arrivati in prossimità del paese si avvidero, con grande stupore, che non c’era nessun incendio: tutto era tranquillo e le famiglie erano ormai andate a dormire. Ripresero allora la strada verso il Monte di Nese, ma ecco che, giunti alla Forcella, si ripeté lo stesso fenomeno di poco prima e la loro casa apparve nitidamente avvolta dalle fiamme.
Altra corsa precipitosa verso Poscante ed altro stupore nel notare che non era in corso nessun incendio. Però, per meglio sincerarsi, questa volta raggiunsero la loro casa dove trovarono i parenti tranquillamente addormentati. Di nuovo risalirono, pur con malavoglia, verso la Forcella dove per la terza volta si ripeté la visione della loro casa in preda ad un furioso incendio. Questa volta il ritorno verso Poscante fu meno precipitoso, ma accompagnato da un’attenta riflessione sul possibile significato di quel fenomeno, che la compagnia interpretò, alla fine, come un monito di Sant’Antonio a rimanersene a casa e smettere di portare nei paesi vicini occasioni di festa peccaminosa, perché basata sul ballo e sulle abbondanti bevute. Quella sera i suonatori fecero voto a Sant’Antonio di porre fine alla loro festosa attività e di dedicare l’intera giornata della festa del santo abate ad onorarne la memoria. La festa fu rispettata anche negli anni seguenti e da allora pare che i Cornolti, questo era il casato dei suonatori, abbiano sempre mantenuto la promessa.
Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001
Si va indietro molti anni: a quel tempo quelli che passavano per la Valle di Poscante di notte e da soli, vedevano o sentivano gli spiriti; e molti che avevano qualche conto da rendere alla giustizia del Signore, passavano pieni di paura. Lungo questa strada si incontravano tre chiesine votive; una notte un uomo che veniva da Zogno per andare a casa sua a Poscante, arrivato alla prima cappelletta, vede davanti al cancello un prete che pregava a voce bassa, tenendo in mano un libro. Lui per essere bene educato lo saluta, ma il prete non risponde. L’uomo allora continua la sua strada, ma quando arriva vicino alla seconda cappelletta, sente come un uomo che brontola e si ferma; si guarda da ogni parte, ma non riesce a vedere nessuno. Fa due passi indietro e improvvisamente rivede lo stesso prete che stava davanti alla seconda cappelletta.
Il prete aveva in mano un libro più grande di quello di prima e pregava con voce più forte. Lui lo saluta ancora e però si sente preoccupato per quello che vede e se ne va via subito di buon passo, senza voltarsi indietro a guardare. Allorché’ giunge in vista della terza cappelletta, sente la voce del prete che prega ancora più forte; si ferma di nuovo mentre il cuore gli batte forte; si fa coraggio e si avvia per la strada che passa accanto alla cappelletta. Il prete era li davanti che pregava con voce ancora più alta: il prete ha in mano un grande foglio di carta bianca e lo porge all’uomo. Lui lo guarda in faccia e s’accorge che il prete e’ uno scheletro vestito da prete: l’uomo resta impietrito e fermo a guardare e intanto il prete scheletro se ne va leggero come l’aria, si allontana e poi sparisce del tutto. Il poveretto, spaurito, guarda il foglio che tiene in mano e vede che c’è scritto l’indirizzo del parroco di Poscante: senza perdere tempo corre a portarglielo.
Il foglio era tutto bianco, ma quando il parroco lo ha preso nelle sue mani si son viste comparire parole scritte; ma solo lui era in grado di leggerle. L’uomo che aveva portato il foglio non poteva capirle. Dopo che il prete le lesse fino in fondo, il foglio ritornò bianco. L’uomo era molto spaventato, ma il parroco di Poscante gli disse che non doveva aver paura, spiegò che lo scheletro che aveva visto era quello di un prete che aveva bisogno di bere per lui e per tutti i morti del paese.
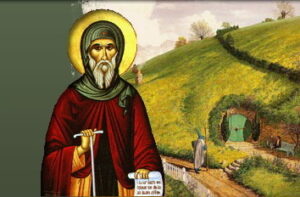
 La càvra del Zambèl
La càvra del Zambèl Ol Rossàl di Santa Brigida
Ol Rossàl di Santa Brigida La casa degli spiriti
La casa degli spiriti La caccia selvatica o cacciamorta
La caccia selvatica o cacciamorta Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle
Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle Il morto che tirava le gambe di notte
Il morto che tirava le gambe di notte La matrignia di Spino al Brembo
La matrignia di Spino al Brembo Cani parlanti
Cani parlanti La pitocca di Olda di Val Taleggio
La pitocca di Olda di Val Taleggio Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca
Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca Gatti permalosi e gatte cornie
Gatti permalosi e gatte cornie La leggenda del Monte Avaro di Cusio
La leggenda del Monte Avaro di Cusio Il lupo di Stabello
Il lupo di Stabello Il castello della Regina
Il castello della Regina Briganti e brigantesse
Briganti e brigantesse Il prete della Valle di Poscante
Il prete della Valle di Poscante La strega nel fenile della pastora di Poscante
La strega nel fenile della pastora di Poscante La cassa da morto del Diavolo
La cassa da morto del Diavolo
 La leggenda della Val d’Inferno (Ornica)
La leggenda della Val d’Inferno (Ornica) Il Folletto della Val Taleggio
Il Folletto della Val Taleggio Il mandriano spergiuro
Il mandriano spergiuro La Maga dei bambini
La Maga dei bambini
 Il Drago volante di Santa Brigida
Il Drago volante di Santa Brigida Streghe bollite in pentola
Streghe bollite in pentola Ifuochi di Sant’Antonio
Ifuochi di Sant’Antonio