Il Drago Volante (così chiamato) abitava nei dintorni di Santa Brigida oggi luogo di villeggiatura, ben noto a tanti. Nessuno sapeva però dove avesse la sua tana, quando appariva come una furia, scoperchiava i tetti delle case con lo sbattere delle ali e poi spariva non dimenticandosi pero’ di portarsi via qualche agnello o capretto. Quando poi il drago decideva di avventurarsi sulle sue prede di notte, si calava dal cielo tenendo tra le zampe 2 grosse gemme che utilizzava per illuminarsi il cammino. Un giorno un certo Bulgher, uomo forte e astuto, decise di sfidare il drago. Il Bulgher di Santa Brigida riuscì a scoprire dove il drago si rifugiava: le pendici del Monte Pugna.
Una notte quatto quatto con una cappa nera sulle spalle, salì sul pianoro e approfittando di un attimo di distrazione del drago si avventò su una delle due gemme fosforescenti ma appena la toccò lanciò un urlo mentre intorno a lui si scatenava l’inferno… vento e tempesta scuotevano gli alberi del bosco. Quella furia si placò solo al mattino, Bulgher più morto che vivo per lo spavento, tornò al paese di Santa Brigida con le mani ancora bruciacchiate e per cento e cento volte ripete’ quello che gli era successo e per secoli lo ripeterono i nonni ai loro nipoti.
Il Drago Volante (così chiamato) abitava nei dintorni di Santa Brigida oggi luogo di villeggiatura, ben noto a tanti. Nessuno sapeva però dove avesse la sua tana, quando appariva come una furia, scoperchiava i tetti delle case con lo sbattere delle ali e poi spariva non dimenticandosi pero’ di portarsi via qualche agnello o capretto. Quando poi il drago decideva di avventurarsi sulle sue prede di notte, si calava dal cielo tenendo tra le zampe 2 grosse gemme che utilizzava per illuminarsi il cammino. Un giorno un certo Bulgher, uomo forte e astuto, decise di sfidare il drago. Il Bulgher di Santa Brigida riuscì a scoprire dove il drago si rifugiava: le pendici del Monte Pugna.
Una notte quatto quatto con una cappa nera sulle spalle, salì sul pianoro e approfittando di un attimo di distrazione del drago si avventò su una delle due gemme fosforescenti ma appena la toccò lanciò un urlo mentre intorno a lui si scatenava l’inferno… vento e tempesta scuotevano gli alberi del bosco. Quella furia si placò solo al mattino, Bulgher più morto che vivo per lo spavento, tornò al paese di Santa Brigida con le mani ancora bruciacchiate e per cento e cento volte ripete’ quello che gli era successo e per secoli lo ripeterono i nonni ai loro nipoti.
Storie di briganti, più o meno famose e romanzesche, sono assai diffuse in tutta la Bergamasca, al punto che la loro narrazione potrebbe occupare un intero libro. In questa sede ci limitiamo a presentare solo alcuni esempi significativi, riferendo anche i casi documentati di due brigantesse che dimostrarono di non essere da meno dei loro più noti compari maschi. A metà dell’Ottocento imperversò in Val Taleggio il brigante Angelo Pessina, detto Tarfù. dal nome dialettale di una grossa larva che si annida nei tronchi degli alberi, di preferenza giovani noci, e si nutre della loro polpa, scavando lunghi cunicoli che arrecano danni gravi e talvolta irreparabili alla pianta. Essendo praticamente impossibile snidare il parassita senza danneggiare il legno, i contadini lo combattono introducendo nel cunicolo un tratto di miccia o uno stoppino imbevuto di liquido infiammabile a cui danno fuoco. Il Tarfù era arrivato in valle all’inizio del 1849, disertore dall’esercito austriaco, nelle cui fila aveva militato fino alla conclusione della guerra contro il Piemonte. L’esercito era in procinto di smobilitare e lui, come tanti altri, di fronte alla prospettiva di un lungo e ostile soggiorno in terra austriaca aveva preferito darsi alla macchia, cosa che del resto aveva già fatto, seppur per un breve periodo, tempo addietro. La Valle Taleggio parve al Pessina il luogo ideale per sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine: guai a farsi mettere le mani addosso dai gendarmi austriaci: essendo disertore recidivo, e per di più in stato di guerra, avrebbe rischiato la fucilazione.
All’inizio si era arrangiato alla meglio, in tutta solitudine, rubando nelle cascine lo stretto necessario per sopravvivere o dandosi alla cattura di uccelli, rane, lumache e quant’altro offrivano i boschi della valle. Ben presto, però, si accorse che ci poteva essere un altro e più redditizio mezzo per campare. Gli era capitato più volte di incontrare, nascosti nelle baite dell’Alben o del Baciamorti, degli sbandati o disertori suoi pari, gente che per un motivo o per l’altro aveva tutte le ragioni per stare alla larga dalla comunità civile, alcuni già dediti al brigantaggio organizzato, altri in procinto di aggregarsi in banda. Che cosa poteva rischiare il Pessina, diventando un brigante, oltre alla pena di morte già meritata con la diserzione? Tanto valeva vivere alla grande più a lungo che poteva, nella remota speranza che qualcosa potesse prima o poi cambiare. La prima rapina fu compiuta ai danni del parroco della Pianca, il quale fu aggredito nella sua canonica e derubato dei soldi e di altri oggetti di valore per l’importo di un migliaio di lire. Probabilmente il Tarfù ebbe in quella prima azione un ruolo subalterno, ma le sue doti di coraggio, l’abilità organizzativa e soprattutto la forte personalità lo portarono quasi subito alla guida del gruppo che verrà poi identificato col suo nome. Questa nuova leadership segnò un salto di qualità nelle successive imprese banditesche. Pochi giorni dopo l’aggressione al parroco della Pianca, la banda fu protagonista di un episodio clamoroso che ebbe per teatro il paese di Sottochiesa. Alla guida di una dozzina di briganti ben armati, il Tarfù penetrò nel municipio e sequestrò il sindaco Locatelli, chiedendo un riscatto di ben tredicimila lire.
Per tutta la giornata il paese rimase in balia dei malviventi che, per convincere la popolazione a consegnare il denaro, sottoposero il sequestrato a ripetuti maltrattamenti e minacce di morte. Alla fine le pretese dei sequestratori si ridussero a poco meno di duemila lire, che vennero effettivamente sborsate. Non senza che il Tarfù si prendesse un interesse supplementare, facendosi consegnare due marenghi d’oro dal vicesindaco, in cambio della garanzia che avrebbe usato la propria autorevole influenza sui compagni nel convincerli a ridimensionare le pretese. Ormai la banda era uscita allo scoperto: l’azione di Sottochiesa aveva rivelato l’identità dei suoi componenti e la polizia aveva spiccato mandati di cattura per ciascuno. Ma di tali mandati la banda Tarfù parve non tener minimamente conto, tanto è vero che mise a segno subito dopo un altro colpo. Calati su Cassiglio, in alta Valle Brembana, i malviventi assalirono l’abitazione di un commerciante e lo rapinarono di sedici talleri. Pochi giorni dopo fu la volta del santuario di Salzana, presso Pizzino, il cui cappellano fu fermato sul sagrato mentre era intento a leggere il breviario e costretto a consegnare i cinque franchi che aveva con sé. Dopo un periodo di oltre un anno, durante il quale dovettero cambiare aria per sfuggire alle attive ricerche dei gendarmi, il Tarfù e i suoi si rifecero vivi nell’agosto del 1850, a spese del parroco di Sottochiesa. Non che i preti, specie da quelle parti, fossero particolarmente ricchi, ma perché non erano pochi i parrocchiani che consegnavano al loro parroco i loro modesti gioielli di famiglia, ritenendo che nella canonica fossero al sicuro, senza contare poi le offerte che venivano fatte in chiesa.
Il parroco fece però in tempo a barricarsi in casa e i banditi non furono in grado di sfondare il robusto portone d’ingresso. Dopo aver cercato a lungo, ma inutilmente un’altra entrata, se ne dovettero andare, non prima però di aver fracassato a sassate alcuni vetri delle finestre. Poi la cattura, avvenuta verso l’autunno di quello stesso anno. La corte marziale lo dichiarò colpevole di duplice diserzione, oltre a rapine, furti e violenze e lo condannò a morte per impiccagione. La sentenza, confermata dal comando militare di Verona, venne eseguita a Bergamo il 28 gennaio 1851. Unica concessione del comando militare, la commutazione delle modalità di esecuzione: alla forca venne sostituita la fucilazione. Un tempo la mulattiera che da Zogno porta al Monte di Nese era assai praticata perché era uno dei percorsi più agevoli per raggiungere la Valle Seriana e Bergamo dalla Valle Brembana. Quanti si recavano da una valle all’altra per trasportare, a dorso di asino o mulo, i loro prodotti, erano soliti sostare in località Gromasnì, un piccolo spiazzo erboso vicino ad una fresca sorgente che sgorga ancora oggi abbondante. Non di rado quello spiazzo era luogo d’incontro e scambio di merci tra mercanti, una specie di mercato dove i prodotti portati dalla città venivano scambiati con quelli delle vallate. Nel 1848 quel luogo fu teatro di un sanguinosa rapina compiuta da una banda di briganti capeggiati da una donna. Vittima della rapina, conclusasi tragicamente, fu Giovan Battista Calvi, un contadino di Poscante il quale si era recato a Bergamo, attraverso la strada del Monte di Nese, per vendere una sua mucca. Passando per Valtesse, era stato notato dalla levatrice del paese, la stessa che faceva servizio anche a Poscante. Costei, appurato che il contadino sarebbe stato di ritorno in serata, senza la mucca, ma con un bel gruzzolo di almeno duecento lire, corse ad avvertire i briganti dell’imminente possibilità di fare un po’ di soldi senza troppe complicazioni. Fu così che levatrice e briganti si appostarono nei pressi della sorgente di Gromasnì, in attesa del ritorno del Calvi, il quale infatti a tarda sera aveva preso la strada di casa, assieme a un compaesano.
Giunto al luogo dell’agguato, il Calvi fu facilmente immobilizzato dai briganti, che erano mascherati e per di più protetti dal buio. Lasciato andare il compagno, si diedero a perquisire il Calvi per sottrargli il denaro, ma il malcapitato, nel tentativo di sottrarsi alla rapina, strappò la maschera alla levatrice e la riconobbe. Costei, allora, per non farsi denunciare, cavò di tasca un lungo coltello e glielo conficcò in un fianco, poi si diede alla fuga con il resto della compagnia, convinta di averlo ucciso. Nel frattempo il compagno di viaggio era giunto a Poscante ed aveva dato l’allarme. I parenti e gli amici del rapinato si precipitarono a prestargli soccorso, ma lo trovarono ormai dissanguato e in fin di vita. Prima di spirare il poveretto ebbe però il tempo di denunciare la colpevole, che pochi giorni dopo venne arrestata, condannata a morte ed impiccata sugli spalti della Fara a Bergamo. Fu l’ultima esecuzione della giustizia austriaca prima delle rivolte patriottiche del 1848. La storia di un’altra brigantessa è ambientata nella media Valle Seriana e precisamente ad Abbazia di Albino dove c’era un’osteria gestita da un’ostessa talmente bella e gentile da richiamare nel locale la migliore clientela della zona. L’ostessa si intratteneva volentieri a chiacchierare con gli avventori e sempre si dimostrava disponibile verso ogni loro esigenza, ma sotto l’apparenza così a modo si celava una ben diversa realtà: la donna era niente meno che a capo di una banda di briganti i quali imperversavano nella media valle e tenevano la base operativa in una caverna del monte Misma, dove nascondevano il bottino e si riunivano per progettare nuove aggressioni ai danni dei malcapitati viandanti che percorrevano le buie strade della zona.
L’ostessa, di notte, si travestiva da uomo e con i capelli che le coprivano le guance simulava una lunga barba biondiccia. Tuttavia non era proprio così malvagia come potrebbe sembrare, infatti, quando nella sua osteria capitava qualche individuo che le andava a genio, faceva di tutto per convincerlo a non inoltrarsi di notte lungo strade deserte e sconosciute e in tal modo gli evitava di cadere nelle mani dei briganti. Ovviamente questo strano comportamento dell’ostessa riguardava solo gli avventori a lei simpatici e solitamente persone giovani ed eleganti, mentre per tutti gli altri non c’era scampo. Fortunato fu quel giovane medico che si era fermato all’osteria per bersi un bicchiere di vino ed essendo ormai prossima la notte fu più volte avvertito dalla donna di non mettersi in viaggio a quell’ora, perché correva il rischio di brutti incontri. Ma siccome il medico non voleva saperne e insisteva per riprendere il viaggio, avendo urgenza di visitare alcuni suoi pazienti, l’ostessa volle a tutti i costi farlo accompagnare da un suo figliolo. La mattina dopo giunse notizia di una sanguinosa aggressione compiuta dalla solita banda ai danni di alcuni mercanti di ritorno dalla fiera di Bergamo. La rapina era stata compiuta proprio lungo la strada dove era da poco transitato anche il giovane medico, il quale ne era però uscito incolume proprio perché in compagnia del ragazzo. Le preziose informazioni fornite alla polizia da alcuni viandanti che erano riusciti a fuggire consentirono di arrestare il marito e il fratello della bella ostessa, la quale risultò pure implicata nell’azione e nel processo che ne seguì si beccò dieci anni di galera.
Tratto da Storie e leggende della Bergamasca di Wanda Taufer e Tarcisio Bottani – Ferrari, Clusone, 2001

 La leggenda del Monte Avaro di Cusio
La leggenda del Monte Avaro di Cusio La dòna del zöch
La dòna del zöch La matrignia di Spino al Brembo
La matrignia di Spino al Brembo Ifuochi di Sant’Antonio
Ifuochi di Sant’Antonio Streghe bollite in pentola
Streghe bollite in pentola Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle
Una messa sacrilega in Val Vedra di Oltre il Colle La càvra del Zambèl
La càvra del Zambèl La casa degli spiriti
La casa degli spiriti Il castello della Regina
Il castello della Regina Cani parlanti
Cani parlanti Il Folletto della Val Taleggio
Il Folletto della Val Taleggio La Maga dei bambini
La Maga dei bambini Briganti e brigantesse
Briganti e brigantesse Il Drago volante di Santa Brigida
Il Drago volante di Santa Brigida Il prete della Valle di Poscante
Il prete della Valle di Poscante
 Il morto che tirava le gambe di notte
Il morto che tirava le gambe di notte La leggenda della Val d’Inferno (Ornica)
La leggenda della Val d’Inferno (Ornica) La caccia selvatica o cacciamorta
La caccia selvatica o cacciamorta La strega nel fenile della pastora di Poscante
La strega nel fenile della pastora di Poscante Gatti permalosi e gatte cornie
Gatti permalosi e gatte cornie
 Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca
Il Serpente aveva la Boccia d’oro in bocca Il mandriano spergiuro
Il mandriano spergiuro Il lupo di Stabello
Il lupo di Stabello
 La pitocca di Olda di Val Taleggio
La pitocca di Olda di Val Taleggio
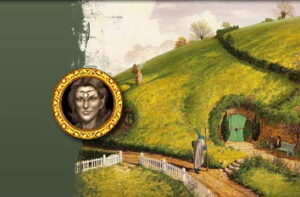


 La cassa da morto del Diavolo
La cassa da morto del Diavolo